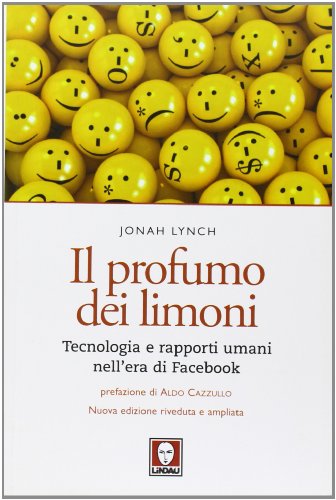Riportiamo la conversazione fra Roberto Maragliano e Carlo Infante, pubblicata su Eduskill, il forum sui nuovi modelli d’apprendimento ospitato all’interno di Idea360, la piattaforma di social innovation.
La conversazione è divisa in cinque parti, qui riportiamo le tre già pubblicate. Questi i link alle pagine di Eduskill:
Prima parte
Seconda parte
Terza parte
Il futuro digitale. Una scommessa che non si compie da sola.
di Carlo Infante
 |
Il filosofo Roberto Maragliano
insegna all'Università Roma Tre |
“Il futuro non è più quello di una volta”, dice Paul Valery. Ed è grazie a questo spunto ironico che inauguriamo questa area di discussione dal titolo EduSkill. I nuovi modelli educativi per trattare di futuro digitale e di come il sistema scolastico, tendenzialmente, inciampi su questo aspetto.
C'è chi rivendica con una certa ostinazione che la scuola non ha nei suoi compiti rincorrere l'innovazione. Lo abbiamo sentito dire più di una volta.
Ma come si fa a ragionare cosi? Non ci si rende conto che si ha a che fare con una generazione che rischia di crescere da sola?
Ne parlo con Roberto Maragliano, una delle figure apripista della didattica multimediale in Italia, in una serrata conversazione (da non considerare un'intervista) che pubblicherò in cinque tratti.
(
Carlo Infante) Iniziamo la nostra conversazione con il parlare di futuro digitale, un futuro che è già inscritto in questo presente e che, come afferma lo scrittore canadese William Gibson, “
è già qui...anche se è mal distribuito”.
Sì, il futuro digitale è come la ricchezza: troppa disparità sociale. Un'opportunità che se non viene rilasciata equamente viene di fatto negata come risorsa possibile. E' una scommessa che non si compie da sola.
Non è solo un problema del digital divide infrastrutturale, per le scarse connessioni internet, ma del divario tra chi vuole e desidera l'innovazione multimediale e chi invece la nega. Si tergiversa, si perde tempo e, nel frattempo, una generazione cresce da sola.
Roberto,quando parliamo di futuro digitale penso a quando ci siamo conosciuti, all'inizio degli anni Novanta, sul fronte di una ricerca diffusa, emergente, sull'apprendimento ipertestuale.
Qualche anno dopo, al Salone del libro di Torino del 1996, hai partecipato ad un'operazione che curai in prima persona; non era solo un convegno ma un'area di laboratorio multimediale con i primi ipertesti realizzati dagli insegnanti delle scuole piemontesi.
S'intitolava
Il futuro digitale. Un presagio, visto dalla prospettiva odierna, dato un sistema educativo che ancora arranca nei confronti dell'innovazione multimediale.
Tu eri protagonista di una tendenza che cercava di rifondare a livello istituzionale il sistema Scuola.
Coordinavi una
commissione ministeriale con l'obiettivo di impostare una strategia pubblica per innovare i modelli d'apprendimento.
Rispetto a quella attività di trincea, contrassegnata da conflitti aspri e immobilismi vari, “cosa è accaduto perché non accadesse nulla”?
Come definiresti gli ostacoli su cui si è infranta quell'avventura di innovazione dei modelli educativi che di fatto esprime
un nuovo paradigma cognitivo?
(
Roberto Maragliano) E' accaduto che abbiamo visto emergere la componente oscura, l'ombra, del crepuscolo di un mondo che non voleva finire.
McLuhan lo aveva intuito: un'era stava finendo e un'altra iniziava. Lo studioso canadese intuisce che quella che sta finendo è l'era della stampa e sostiene che, nel passaggio, quell'era ha dentro di sé sia i residui dell'era precedente sia le intuizioni per quella successiva. In questa era di passaggio, come in tutti i crepuscoli, c'è sia la luce sia l'ombra.
Ognuno poi interpreta come crede ciò che è ombra e ciò che è luce, a seconda dei punti di vista.
Un animale notturno vede l'aspetto negativo nella luce.
C'è luce e c'è ombra in questa radicale mutazione della cultura della scrittura. E penso a come quel mondo abbia nei secoli definito la marcatura dei confini, quelli della strutturazione analitica, delle logiche sistematizzanti dell'approfondimento, del pensiero razionale...
(
Carlo Infante) Sì, quella cultura ha teso a territorializzare, a definire dentro schemi preordinati gli ambiti della conoscenza. Tutto il pensiero alfabetico basato sull'inesorabile sviluppo lineare ha territorializzato il sapere…
(
Roberto Maragliano) Nel senso che l'ha sondato, organizzato, strutturato, gli ha costruito intorno tanti bei giardini epistemologici. Qui inizia il mio giardino e lì finisce il tuo. Il giardino del terzo incomodo è ovviamente esterno ai nostri due giardini. E' straniero. Ogni tanto c'è qualcuno che fa un piccolo volo superiore e vede le cose, fermo restando che la pertinenza del mio giardino è questa. L'importante per questa logica è tenere tutto separato, in una logica bloccata che segmenta il sapere.
C'è per fortuna un'altra cultura che attraversa le cose, ma non dall'alto, le attraversa dal di dentro, non riconosce i confini. Si muove come una talpa, ad un altro livello...
Mediamorfosi. La metamorfosi dei linguaggi, tra oralità e ipermedia
(
Carlo Infante) C'è un punto cardine per ciò che riguarda la questione educativa. Riguarda la veloce trasformazione dei linguaggi scandita dall'evoluzione tecnologica in atto.
Molti pensano che tutto questo meccanizzi, renda algida, disumanizzante, la comunicazione. Invece è proprio il contrario. Paradossalmente l'approccio con ciò che chiamiamo multimedialità interattiva sta rimettendo in gioco i fattori sensoriali, irrompe il principio attivo dell'oralità nell'immediatezza della scrittura on line. Ci si emancipa dalle strutture rigide del pensiero lineare grazie all'ipertesto che ripercorre le dinamiche combinatorie e associative del pensiero umano.
Tra l'oralità e l'ipermedia c'è una connessione profonda: si tende a rivalutare la dimensione naturale del comunicare.
(
Roberto Maragliano) Assolutamente si. In una visione naturalmente di tipo circolare ci sono i ritorni. Riemerge la necessità di dare senso alla comunicazione per quello che è: condividere, entrare in relazione con ciò che ci circonda. Si tratta di una visione che dal punto di vista filosofico ed epistemologico è diversa dalla visione lineare tipica del sistema della scrittura affermato con la tecnologia della stampa.
In questa logica la fine dell'egemonia della stampa, segna il recupero della dimensione linguistica, nel senso orale, corporale, fisica, anche sensuale e sentimentale, più propensa a prendere la totalità dell'uomo, quindi in linea con le scoperte della psicanalisi.
Già le avanguardie, sia sul piano artistico sia sul piano scientifico, avevano rotto con i sistemi lineari. Era accaduto già nei primi anni del Novecento, inventando scritture e visioni straordinarie.
Queste intuizioni sono state fatte proprie dall'industria della comunicazione che le ha sapute integrare all'universo commerciale. Pensate al cinema e alla televisione e anche la radio e il telefono. Tutto questo si sta amplificando sul versante del digitale. Oggi ci troviamo di fronte a questa situazione: una tradizione di cultura scritta che è il punto di riferimento fondamentale per l'accademia e la scuola e un universo mediale verso cui confluisce tutto il mondo, i giovani in testa.
Un mondo pervaso dalle logiche del consumo, senza offrire strumenti elaborazione.
(
Carlo Infante) Eppure il web, a differenza dei sistemi del broadcast radio-televisivo, permette di agire in prima persona, senza grandi investimenti: permette cioè di fare qualcosa, subito, per riequilibrare una situazione di gravissimo divario tra i modelli educativi e un mondo che sta cambiando esclusivamente sotto il segno dei consumi commerciali. E' doveroso che il sistema della formazione gestisca l'aspetto cognitivo dei nuovi media.
Quale energia culturale libera l'ipertestualità?
(
Roberto Maragliano) La semantica delle connessioni va esercitata per dare il senso alla comunicazione integrata al processo educativo. E' una questione che riguarda il nostro rapporto con la vita che si trasforma e di conseguenza la nostra relazione con il sapere. Abbiamo diecimila cose in testa, è sempre stato così, anche se oggi di informazioni ne circolano sempre di più. Si sta delegando alla rete i meccanismi della memoria che prima si gestivano autonomamente. Ma possiamo acquisire questi meccanismi e tradurli in un processo culturale capace di lavorare per associazioni che arrivino ad interpretare le connessioni ipertestuali del web e convertirle in nuovo modo di organizzare il pensiero.
(
Carlo Infante) Ci siamo, è qui il punto. E' questa la leva da esercitare perché il sistema educativo investa maggiore attenzione su questi processi. Ciò che viene definito tecnologia è sostanzialmente modificazione degli assetti culturali più profondi.
Palestre ludico-educative e nuove attitudini cognitive
(
Carlo Infante) Parliamo di modificazioni culturali determinate dall'evoluzione tecnologica ma per la nuova generazione non si pone la questione. Non si modifica nulla: i ragazzi stanno crescendo dentro questo mondo digitale.
Ricordo dell'esperienza fatta insieme nel 1994 per la Biennale dell'Adolescenza di Cagliari dove fu presentato il primo medialab italiano. Già allora ci si interrogava su come i videogame rappresentassero una palestra ludico-educativa per i più piccoli. Ci misuriamo con i nativi digitali, un termine che Mark Prensky ha coniato con successo nel 2001, per fare in modo che la nuova generazione sia in grado di affrontare una società sempre più complessa. Il nodo da sciogliere è nel come armonizzare la nostra impostazione culturale con le loro nuove attitudini cognitive.
(
Roberto Maragliano) Da parte della cultura accademica, da sempre, c'è il tentativo di inscatolare dentro un sistema stabile il giovane che si deve formare.
L'idea del nativo digitale sta prendendo piede e per molti è funzionale ad una giustificazione per non fare nulla.
Si dicono: quelli sono nati così, che cosa ci possiamo fare? Nel momento in cui diventa un'etichetta rischia di diventare una specie di alibi. Lo si vuole far passare come un problema che riguarda le generazioni, mentre l'avvento del digitale riguarda tutti noi.
Mette in discussione l'identità di tutti, anche di coloro che non sanno neppure utilizzare il web anche se poi insegnano materie che hanno a che fare con le tecnologie.
Questo sfasamento rende molto opaco l'atteggiamento di molti educatori nei confronti di una nuova generazione che si chiede “dove andiamo, cosa facciamo” nella frequentazione del web.
Non si può accettare che non si riesca a coinvolgere questi ragazzi del processo formativo.
La grande novità della rete è che è semplice e complessa allo stesso tempo.
Nella sua semplicità d'uso per i giovani va trovato, da parte degli educatori, un riconoscimento della complessità per arrivare alla conclusione dei ragionamenti, per la loro consapevolezza culturale.
Un po' di modestia farebbe tanto bene alla cultura accademica per imparare a mettere in relazione il semplice con il complesso. Ma purtroppo c'è una grande povertà epistemologica nel campo accademico per fare questo lavoro.
(
Carlo Infante) Infatti affrontare i nuovi modelli educativi riguarda sempre di più la riconfigurazione culturale dei formatori per intercettare il sentire dei nuovi digitali. Devono mettersi in discussione. Quando pensiamo all'idea dell'apprendimento lungo una vita … E' di questo che si tratta.
(
Roberto Maragliano) E' duro ma anche affascinante riconoscere che oggi in molti devono rivedere le impostazioni culturali su cui hanno fondato la loro professionalità docente. E' difficile in questo processo accettare di non avere più i punti fermi su cui s'è costruita un'identità professionale.
(
Carlo Infante) Bisogna sapersi mettere in gioco. E guardarsi intorno riconoscendo gli input che arrivano al di fuori del mondo chiuso della scuola.
(
Roberto Maragliano) Pensa a tutto il mondo del consumismo verso cui i nativi digitali sono naturalmente attratti. Il mondo della scuola lo ignora o lo demonizza. C'è una volontà di tenere separata la scuola dalla società nelle sue espressioni più quotidiane. In questa situazione c'è una schizofrenia del sistema educativo.
Il nativo digitale ha un patrimonio di intelligenza dentro si sé che esprime spesso nell'essere un consumatore attivo dei nuovi media. E' estremamente attento nel consumismo tecnologico e incredibilmente distratto sul versante scolastico. Non si ritrova in una scuola che gli impone di essere intelligente secondo una logica che non alberga più nel mondo delle connessioni web.
 Vi sono alcune punte di eccellenza. Peró non vi è mai stato un programma in grado di favorire la digitalizzazione delle scuole e non vi è mai stata una sperimentazione, su larga scala, di nuovi modi di apprendimento.
Vi sono alcune punte di eccellenza. Peró non vi è mai stato un programma in grado di favorire la digitalizzazione delle scuole e non vi è mai stata una sperimentazione, su larga scala, di nuovi modi di apprendimento.